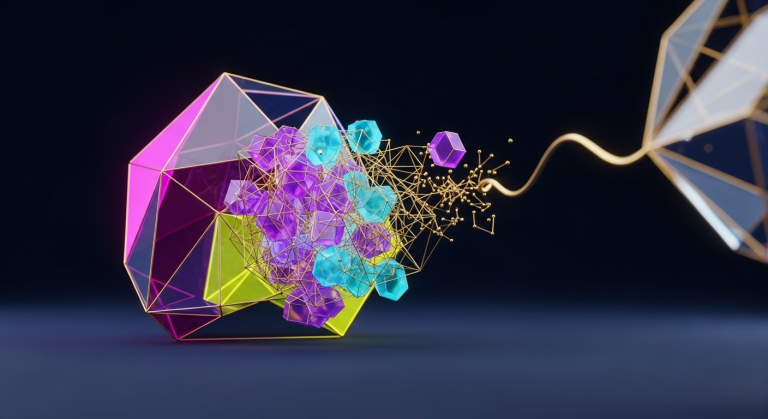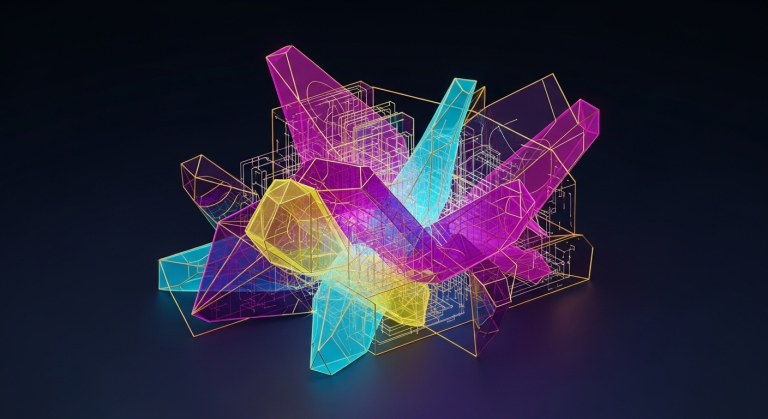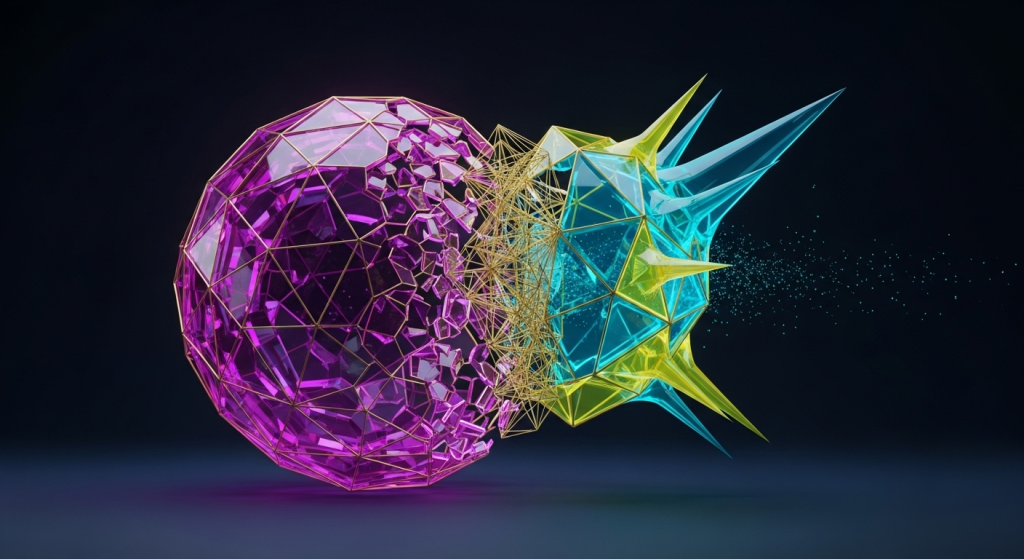OpenMind mira a superare la frammentazione del settore robotico con OM1, un sistema operativo universale e open source, e FABRIC, un protocollo che fornisce alle macchine una lingua comune per comunicare e collaborare.
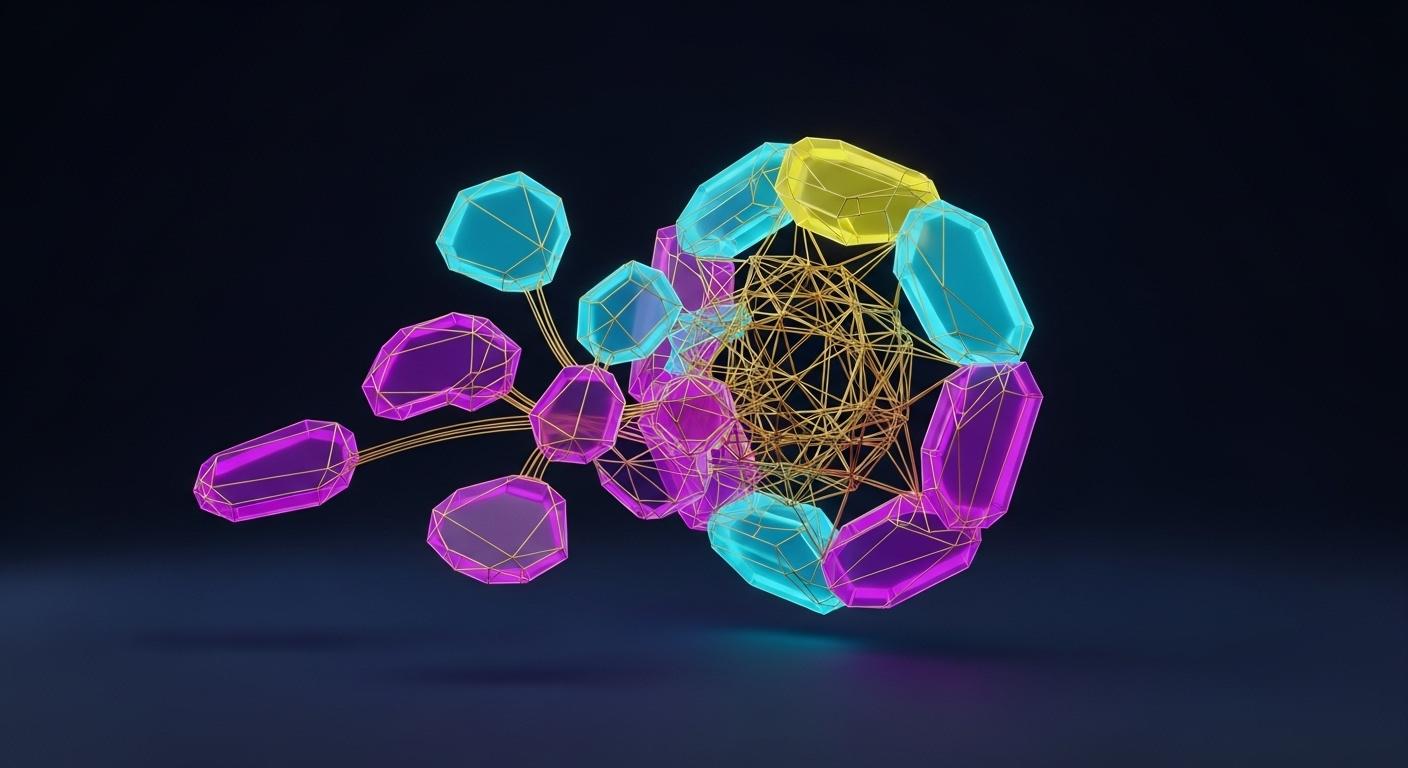
[In pillole] La sintesi per chi va di fretta:
L'azienda OpenMind di San Francisco ha lanciato OM1, un sistema operativo universale e open source per i robot. L'iniziativa mira a superare la frammentazione del settore, promuovendo comunicazione e collaborazione tra macchine di produttori diversi, sull'esempio di Android. Con un finanziamento di 20 milioni di dollari, OpenMind sposta l'innovazione dall'hardware al software per una robotica più adattabile.
Una visione che parte dal software, non dal metallo
A guidare OpenMind c’è Jan Liphardt, fondatore e amministratore delegato con un profilo piuttosto atipico per il settore. Professore all’Università di Stanford, la sua carriera si è sviluppata all’intersezione tra fisica, biotecnologia, privacy dei dati e intelligenza artificiale.
Liphardt non è solo un accademico, ma ha maturato una conoscenza diretta e pratica delle interazioni tra umani e macchine, avendo vissuto per anni con robot umanoidi e quadrupedi nella sua stessa casa.
Questa esperienza personale gli ha permesso di osservare come le persone, e in particolare i bambini, interagiscono con queste tecnologie in un contesto quotidiano, notando limiti e potenzialità che spesso sfuggono nei laboratori di ricerca.
È da questa osservazione che nasce la convinzione che il vero ostacolo all’evoluzione della robotica non sia più di natura meccanica, ma logica e comunicativa.
Secondo Liphardt, i robot di oggi sono “intrappolati in ecosistemi di un singolo produttore che ne limitano la collaborazione e non riescono ad adattarsi alla complessità del mondo reale”. La sua proposta, quindi, è quella di fornire il “tessuto connettivo che all’industria della robotica è sempre mancato”.
Si tratta di un approccio che ricorda molto da vicino quanto accaduto nel mondo degli smartphone, dove l’arrivo di sistemi operativi aperti come Android ha permesso a innumerevoli produttori di hardware di competere su un terreno comune, stimolando un’innovazione rapidissima e una diffusione capillare dei dispositivi. La promessa è quella di replicare questo modello, offrendo una base software solida e flessibile su cui chiunque possa costruire.
Ma l’ambizione di un sistema operativo condiviso si scontra con una difficoltà tecnica non banale: come far comunicare tra loro macchine costruite da aziende diverse, con scopi e programmazioni differenti?
Il protocollo FABRIC: una lingua comune per le macchine
La risposta di OpenMind a questa sfida si chiama FABRIC, un protocollo di coordinamento decentralizzato che funziona come uno strato di comunicazione sicuro e universale per i robot.
Questo sistema è forse il vero cuore tecnologico del progetto, poiché affronta uno dei problemi più sentiti nel settore: l’assenza di un metodo standardizzato che permetta a macchine diverse di scambiarsi informazioni in modo affidabile.
FABRIC consente ai robot di verificare l’identità di altre macchine nelle vicinanze, condividere dati contestuali sull’ambiente e coordinare le proprie azioni, indipendentemente dal produttore o dal software specifico che utilizzano.
Ad esempio, un robot che ha imparato a orientarsi in un nuovo ambiente può condividere questa conoscenza con altri, accelerando il processo di adattamento collettivo senza bisogno di un intervento umano diretto per ogni singola macchina.
Come descritto da The Robot Report, questo protocollo agisce come un “livello di fiducia” che permette ai robot di collaborare in modo efficace.
– Leggi anche: OpenAI: dalla Rivoluzione di ChatGPT alla Corsa per la Robotica e l’AGI
Nella visione di OpenMind, macchine che utilizzano FABRIC “possono capire dove si trovano, chi c’è nelle vicinanze e cosa fare dopo”.
Le implicazioni pratiche sono notevoli e spaziano dalla manifattura intelligente, dove robot di diverse linee di produzione potrebbero coordinarsi per ottimizzare il flusso di lavoro, fino ai trasporti autonomi e alle applicazioni domestiche più sofisticate, dove più dispositivi potrebbero collaborare per assistere le persone.
La logica è quella di creare una sorta di intelligenza collettiva, in cui ogni macchina contribuisce con la propria esperienza a un patrimonio di conoscenze condiviso. Una visione così ambiziosa, tuttavia, richiede non solo una solida base tecnologica ma anche un cospicuo sostegno economico per poter competere in un settore dominato da giganti della tecnologia.
peraltro, questavisione di intelligenza collettiva, per quanto futuristica, ha un’applicazione concreta e matura in un settore specifico. È proprio nei contesti di manifattura avanzata che i Sistemi di Esecuzione della Produzione (MES) svolgono da anni un ruolo simile, agendo come il “sistema nervoso” che sincronizza macchinari eterogenei e ottimizza il flusso di lavoro in tempo reale.
Il parere degli investitori e i primi test sul campo
Il round di finanziamento da 20 milioni di dollari è stato guidato da Pantera Capital, un nome noto nel mondo degli investimenti tecnologici, e ha visto la partecipazione di altri fondi importanti come Ribbit, Coinbase Ventures e Lightspeed Faction.
Un sostegno così ampio suggerisce che l’approccio di OpenMind non è percepito come un semplice esercizio accademico, ma come una soluzione potenzialmente praticabile a un problema concreto. Le dichiarazioni degli investitori riflettono questa fiducia.
Nihal Maunder di Pantera Capital ha sottolineato come l’idea di una rete di intelligenza aperta per le macchine sia quasi ovvia a posteriori, paragonando l’impatto potenziale di OpenMind a quello che Linux ha avuto per il software o Ethereum per le applicazioni decentralizzate.
Pamela Vagata, partner di Pebblebed ed ex membro fondatore di OpenAI, ha lodato il rigore tecnico del progetto, definendolo “esattamente ciò che è necessario per sviluppare una robotica sicura e adattabile su larga scala“.
Tuttavia, le dichiarazioni entusiaste degli investitori sono una costante nel mondo delle startup, e il vero banco di prova resta sempre l’applicazione pratica. OpenMind sembra consapevole di questo e ha adottato una strategia di sviluppo che privilegia i test nel mondo reale rispetto a lunghe fasi di ricerca teorica.
Già a settembre del 2024, l’azienda aveva messo in funzione i suoi primi dieci cani robotici equipaggiati con OM1, con lo scopo di raccogliere dati e feedback diretti dagli utenti in ambienti non controllati. Questo approccio pragmatico è finalizzato a comprendere come i robot si comportano e vengono percepiti in contesti reali, lontani dalle condizioni ideali di un laboratorio.
Se l’intelligenza artificiale rappresenta il cervello e la robotica il corpo, ha spiegato Liphardt, “la coordinazione è il sistema nervoso. Senza di essa, non c’è intelligenza, solo movimento”.
La scommessa di OpenMind è proprio quella di costruire quel sistema nervoso, ma resta da vedere se questo modello aperto riuscirà a imporsi su un mercato abituato a ragionare per silos e a proteggere gelosamente le proprie innovazioni.