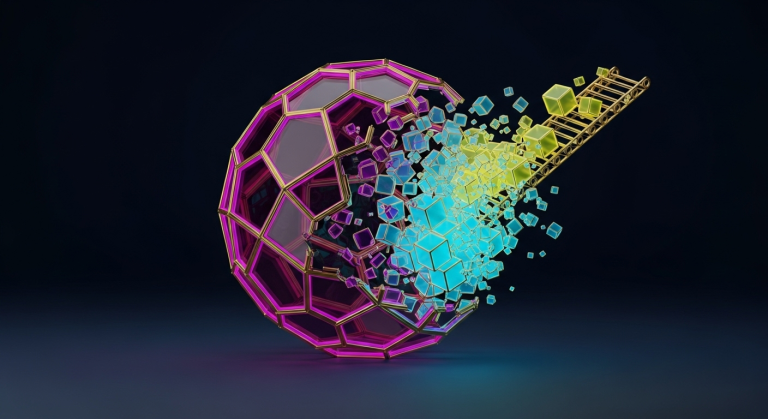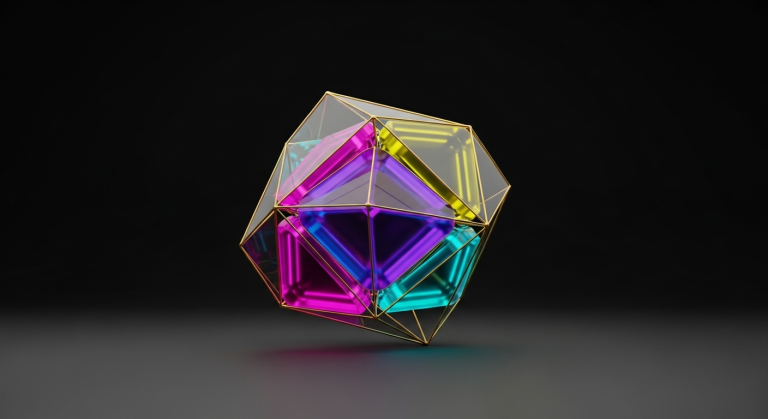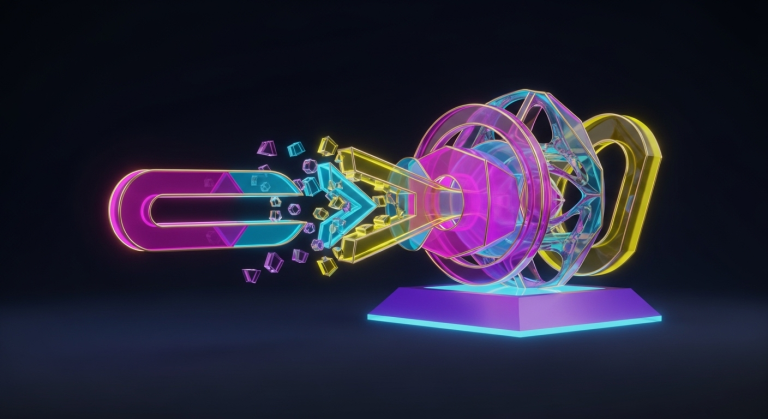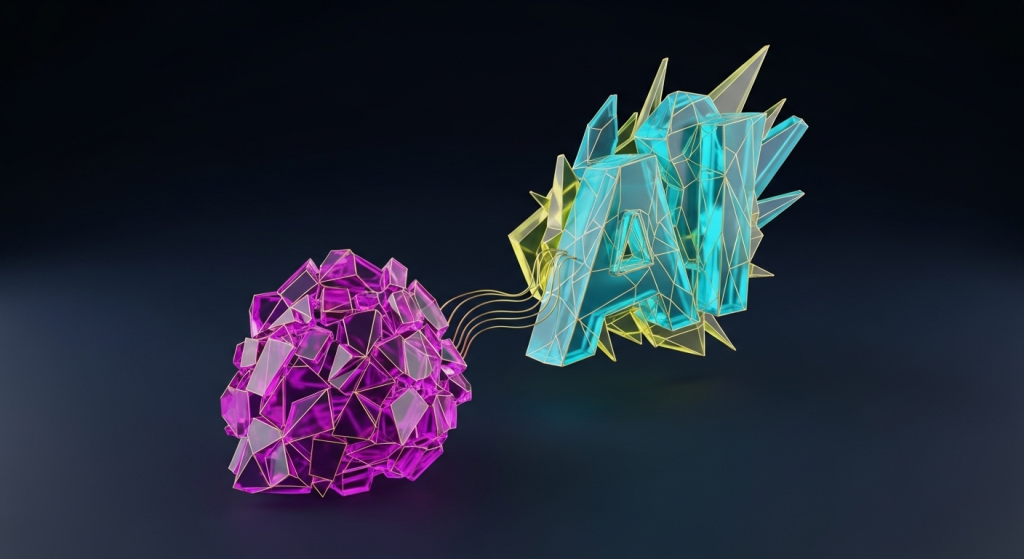Il settore è spinto da una crescente domanda di efficienza e da macchinari sempre più intelligenti, capaci di collaborare con l’uomo e muoversi autonomamente, pur ponendo complesse questioni di competenze e impatto sociale.

[In pillole] La sintesi per chi va di fretta:
Il mercato globale della robotica è in forte espansione, con previsioni di crescita da 47,8 miliardi di dollari nel 2024 a 211,1 miliardi entro il 2034. L'intelligenza artificiale e i robot collaborativi (cobot) stanno rivoluzionando industria e logistica, ridefinendo la collaborazione uomo-macchina e spingendo la domanda di efficienza. Tale evoluzione pone però sfide importanti per le nuove competenze richieste.
L’accelerazione dell’automazione e i suoi protagonisti
A guidare questa rivoluzione sono poche, grandi aziende che da anni definiscono gli standard tecnologici del settore. FANUC, per esempio, è uno dei nomi più riconoscibili e offre un catalogo di oltre cento modelli di robot industriali, apprezzati per la loro affidabilità e versatilità.
La sua recente serie di robot collaborativi, o “cobot”, noti come CRX, è stata progettata per essere programmata in modo intuitivo e per operare in sicurezza a fianco del personale umano, abbattendo le tradizionali barriere che separavano macchine e lavoratori.
Un altro gigante del settore è la tedesca KUKA, i cui bracci robotici arancioni sono ormai un’icona dell’automazione. La sua offerta spazia da modelli agili e veloci a colossi come il KR 1000 Titan, in grado di manipolare carichi superiori a una tonnellata.
Accanto a questi attori consolidati, emergono realtà che puntano a rendere la tecnologia più accessibile. È il caso del progetto Blue, sviluppato dall’Università di Berkeley, un braccio robotico a basso costo pensato per la ricerca e per le piccole imprese che finora non potevano permettersi investimenti ingenti in automazione.
Questo allargamento della base di utenti è un segnale importante, perché indica che l’automazione sta uscendo dai confini delle grandi multinazionali per diventare uno strumento potenzialmente alla portata di un numero molto più vasto di aziende.
Il mercato, tuttavia, non è solo una questione di hardware; è sempre più il software e l’intelligenza artificiale integrata a fare la differenza, permettendo ai robot di svolgere compiti non ripetitivi e di adattarsi a situazioni impreviste.
Questa spinta verso una maggiore flessibilità sta cambiando radicalmente il modo in cui i robot vengono percepiti e utilizzati, spostando il focus dalla semplice sostituzione del lavoro manuale alla creazione di nuove forme di collaborazione.
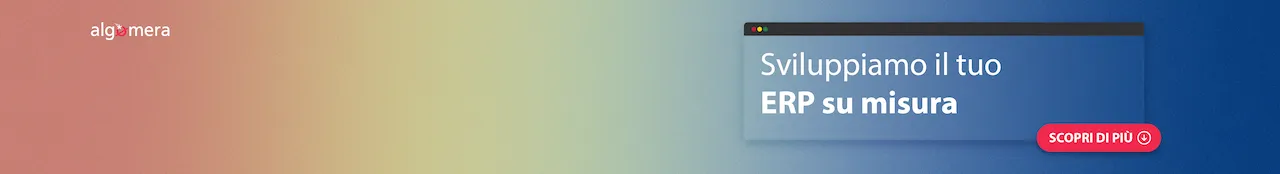
Robot collaborativi e nuove frontiere operative
La distinzione tra robot industriali tradizionali e robot collaborativi è fondamentale per comprendere la direzione del mercato.
I primi sono macchine potenti e veloci, progettate per operare in ambienti controllati e isolate da gabbie di sicurezza per proteggere gli operatori. I cobot, al contrario, sono progettati fin dall’inizio per condividere lo stesso spazio di lavoro degli esseri umani.
Dotati di sensori avanzati, sono in grado di fermarsi istantaneamente in caso di contatto, rendendo la collaborazione sicura e diretta. Secondo un’analisi di settore pubblicata su Tech4Future, la produzione di cobot, sebbene ancora una frazione del totale, è in costante aumento, passando da 19.000 a 22.000 unità tra il 2018 e il 2020.
Questa tendenza è particolarmente evidente in mercati maturi come quello tedesco, dove la domanda di cobot sta crescendo a un ritmo sostenuto. Le applicazioni, spesso coordinate da un sistema di esecuzione della produzione, sono estremamente varie: un cobot può assistere un operaio nell’assemblaggio, sollevare carichi pesanti o eseguire controlli di qualità meticolosi.
– Leggi anche: Amazon e l’automazione: mezzo milione di posti di lavoro a rischio?
Un esempio concreto è la partnership tra Cobot Lift ed EuroTECH, finalizzata a distribuire in Germania soluzioni che integrano la tecnologia del vuoto nei cobot per la movimentazione di pannelli e lastre, un compito faticoso e ripetitivo se svolto manualmente. Questo tipo di automazione non sostituisce l’operaio, ma ne aumenta le capacità, liberandolo dalle mansioni più logoranti e permettendogli di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.
Se i cobot ridefiniscono la collaborazione uomo-macchina sul posto di lavoro, un’altra categoria di robot sta cambiando il concetto stesso di movimento all’interno degli spazi industriali e commerciali.
Si tratta dei Robot Mobili Autonomi (AMR), veicoli che agiscono come il braccio operativo dei sistemi di gestione del magazzino, muovendosi liberamente per trasportare merci e materiali. Il mercato degli AMR, spinto dalla crescita dell’e-commerce, sta vivendo un’espansione ancora più rapida di quello della robotica stazionaria.
Tra dinamiche globali e interrogativi sul futuro
L’adozione della robotica non è uniforme a livello globale e presenta dinamiche molto diverse a seconda delle aree geografiche. La Cina si conferma il mercato più importante e dinamico, assorbendo da sola oltre la metà della domanda mondiale di robot industriali.
Questo primato è il risultato di una precisa strategia governativa volta a modernizzare l’apparato produttivo del paese e a compensare i cambiamenti demografici, come l’invecchiamento della popolazione e l’aumento del costo del lavoro. Con quasi due milioni di robot industriali già operativi nelle sue fabbriche, la Cina non è più solo la “fabbrica del mondo” basata sulla manodopera a basso costo, ma un laboratorio avanzato di automazione su larga scala.
Tuttavia, questa transizione imponente solleva anche questioni complesse.
La diffusione pervasiva dell’automazione richiede investimenti enormi e, soprattutto, nuove competenze. Uno dei problemi più sentiti dalle aziende non è più solo l’acquisto della tecnologia, ma la difficoltà nel reperire professionisti in grado di programmare, gestire e mantenere sistemi robotici sempre più sofisticati. L’automazione, introdotta in parte per sopperire alla carenza di manodopera, rischia paradossalmente di creare un nuovo e più complesso vuoto di competenze specializzate, mettendo in discussione i modelli formativi tradizionali.
In questo contesto, l’intelligenza artificiale cessa di essere un concetto astratto per diventare, come suggerisce Wall Street Italia, l’incarnazione fisica della trasformazione digitale.
I bracci robotici e i veicoli autonomi sono il “corpo” che permette all’AI di agire nel mondo reale.
La convergenza tra queste due tecnologie sta aprendo possibilità che fino a pochi anni fa appartenevano alla fantascienza, ma pone anche le basi per una riflessione non più rimandabile sull’impatto sociale ed economico di un mondo in cui la distinzione tra lavoro umano e lavoro meccanico diventa sempre più sfumata.