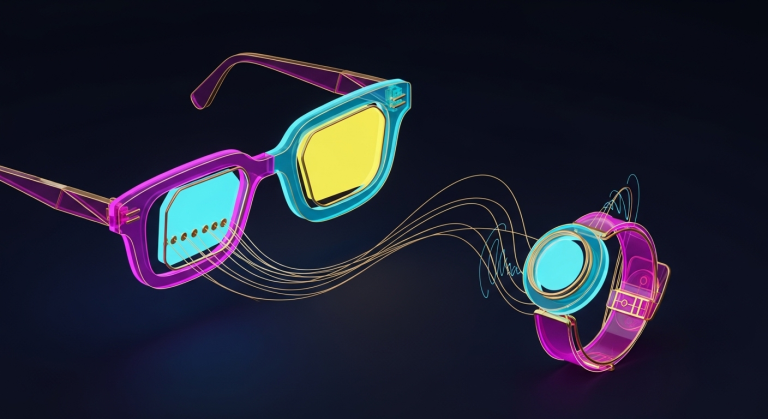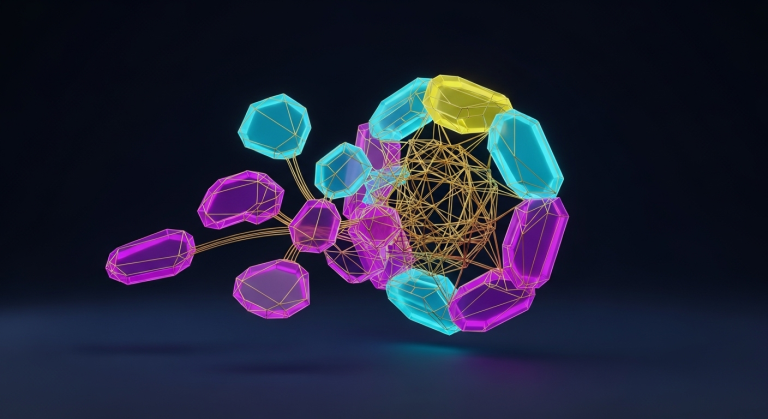L’iniziativa, prevista da settembre del prossimo anno in alcuni Istituti Tecnici Superiori della Puglia, introdurrà un assistente didattico basato sull’intelligenza artificiale per affiancare professori e studenti.
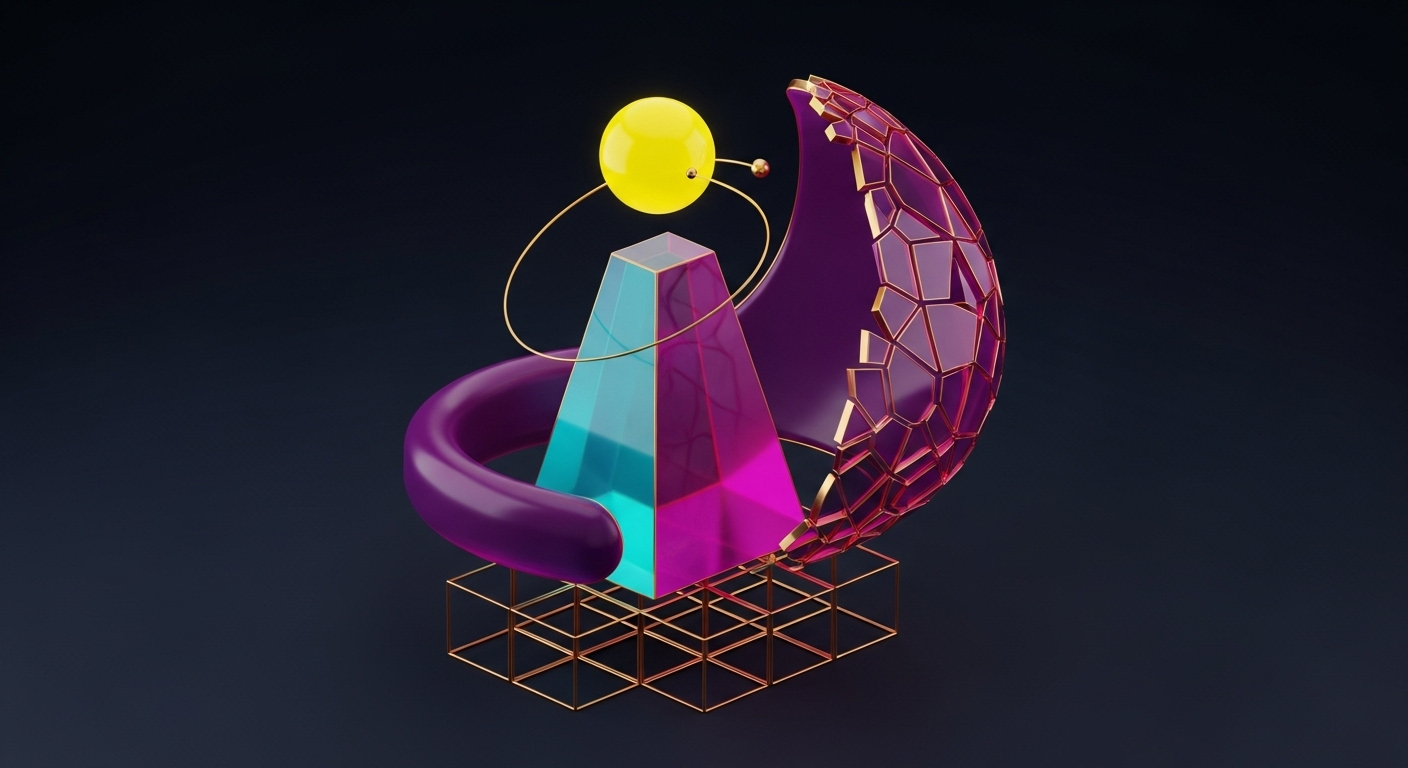
[In pillole] La sintesi per chi va di fretta:
Dal settembre 2025, in alcuni Istituti Tecnici Superiori della Puglia, debutterà il primo assistente didattico basato su intelligenza artificiale negli ITS italiani. L'iniziativa mira a supportare docenti e studenti, personalizzando l'apprendimento e alleggerendo il carico di lavoro. Il progetto, pur innovativo, solleva importanti interrogativi etici e pedagogici sul futuro dell'istruzione e il ruolo umano.
Un assistente artificiale in cattedra
Da settembre del prossimo anno, in alcuni Istituti Tecnici Superiori della Puglia, studenti e professori troveranno in aula un collega in più.
Non sarà un docente di ruolo, né un supplente, ma un assistente didattico basato su intelligenza artificiale, il primo di questo tipo a essere introdotto in modo strutturato nel sistema degli ITS italiani.
La notizia, riportata da Forbes, descrive l’iniziativa come un progetto pensato per supportare l’insegnamento e l’apprendimento, affiancando e non sostituendo il personale umano.
È un passo notevole per l’istruzione italiana, che sceglie un contesto molto specifico come quello degli ITS per avviare una sperimentazione che, inevitabilmente, solleva tanto interesse quanto interrogativi.
L’idea è quella di un software capace di interagire con gli studenti, forse per personalizzare i percorsi di studio, fornire spiegazioni aggiuntive o gestire esercitazioni, e allo stesso tempo di alleggerire il carico di lavoro dei docenti, magari automatizzando la correzione di alcuni compiti o la preparazione di materiali didattici.
Sebbene i dettagli operativi e il nome dell’azienda tecnologica che fornirà la piattaforma non siano ancora stati resi pubblici, il concetto stesso di “docente AI” segna un punto di rottura rispetto alle tradizionali tecnologie educative, come le lavagne interattive o le piattaforme di e-learning.
Qui non si tratta solo di digitalizzare contenuti, ma di introdurre un agente attivo, capace di dialogare e adattarsi, nel delicato processo della formazione.
Ma questo nuovo strumento non nasce nel vuoto, e per capire la sua portata è necessario osservare il sistema in cui si inserisce.
Il contesto pugliese e la scelta degli istituti tecnici superiori
La scelta di avviare questo progetto proprio negli Istituti Tecnici Superiori non è casuale. Gli ITS rappresentano un segmento particolare del sistema educativo italiano: sono scuole di alta specializzazione tecnologica, create per formare “super-tecnici” in aree strategiche per l’economia, dal digitale alla meccatronica, dal turismo all’agroalimentare.
Sono strutturati come fondazioni a cui partecipano imprese, università ed enti locali, e il loro punto di forza è proprio il forte legame con il mondo del lavoro.
Realtà come l’ITS Academy Apulia Digital sono nate proprio per rispondere a una domanda precisa di competenze innovative che il sistema universitario tradizionale a volte fatica a intercettare con la stessa rapidità. In un ambiente del genere, orientato all’innovazione e alla tecnologia applicata, l’introduzione di un assistente AI appare quasi come una naturale evoluzione.
Questa spinta verso il futuro, però, si innesta su un tessuto che vive le complessità di sempre. Mentre si progetta l’arrivo dell’intelligenza artificiale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia è infatti impegnato in attività molto più tradizionali, ma non meno fondamentali.
– Leggi anche: Meta Ray-Ban Display: Gli occhiali smart ora hanno uno schermo e si controllano con il polso
Per l’anno scolastico 2025-2026, ad esempio, è stato assegnato alla regione un contingente di 2.401 posti per le immissioni in ruolo del personale docente, un numero che racconta di un sistema che ancora si fonda sulla necessità di trovare, assumere e inserire insegnanti in carne e ossa.
È un dualismo interessante: da un lato la ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare la didattica, dall’altro la gestione quotidiana di concorsi, graduatorie e assegnazioni di cattedre che costituisce la spina dorsale della scuola italiana.
Questo apparente contrasto tra futuro e presente rivela una verità più profonda. L’efficacia di un assistente AI non si misurerà nel vuoto, ma nella sua capacità di supportare concretamente il corpo docente. Per questo, ogni innovazione tecnologica deve poggiare su una solida e moderna gestione delle risorse umane, un sistema che valorizzi il personale “in carne e ossa”, ne gestisca i percorsi e ne liberi il potenziale, rendendolo pronto ad accogliere nuovi strumenti.
Un esperimento che solleva domande più ampie
Al di là del suo valore come progetto pilota, l’introduzione di un assistente AI nella didattica forza una riflessione più profonda sul futuro dell’istruzione e sul ruolo stesso dell’insegnante. L’obiettivo dichiarato è quello di “supporto”, ma il confine tra supporto e sostituzione può diventare labile.
Se un software si dimostrerà efficace nel personalizzare l’apprendimento per ogni singolo studente, gestendo i suoi tempi e le sue difficoltà in modo più granulare di quanto possa fare un docente con una classe di venticinque persone, quale diventerà il compito principale dell’insegnante umano?
La risposta ottimistica è che l’insegnante potrà finalmente liberarsi delle mansioni più ripetitive per concentrarsi sugli aspetti più umani della formazione: il dialogo, la motivazione, lo sviluppo del pensiero critico e la gestione delle dinamiche di gruppo. In questa visione, la tecnologia non toglie lavoro, ma lo qualifica.
Tuttavia, sorgono anche questioni più critiche.
Chi progetterà questi algoritmi? Con quali valori e obiettivi pedagogici? Se la tecnologia viene fornita da grandi aziende multinazionali, c’è il rischio che i modelli educativi proposti siano standardizzati e orientati più a logiche di mercato che a un progetto formativo pubblico e inclusivo.
Queste domande critiche spostano il focus dalla tecnologia in sé al modo in cui viene creata. La risposta a queste sfide etiche non risiede in un prodotto preconfezionato, ma in un processo consapevole di sviluppo di intelligenze artificiali, in cui i valori di inclusività non sono un’aggiunta finale, ma il fondamento stesso su cui l’intero algoritmo viene costruito.
E poi c’è il tema dei dati. Ogni interazione tra lo studente e l’assistente AI genererà una quantità enorme di informazioni sul suo modo di apprendere, sui suoi errori, sui suoi progressi. A chi apparterranno questi dati? Come verranno utilizzati per valutare non solo gli studenti, ma anche l’efficacia degli stessi docenti umani?
L’esperimento pugliese diventa così un banco di prova non solo tecnologico, ma anche etico e politico. Le sue risposte, nel bene e nel male, potrebbero influenzare il modo in cui penseremo la scuola in Italia per i prossimi decenni, definendo un nuovo equilibrio tra l’insostituibile valore dell’interazione umana e le potenzialità, ancora in gran parte inesplorate, dell’intelligenza artificiale.