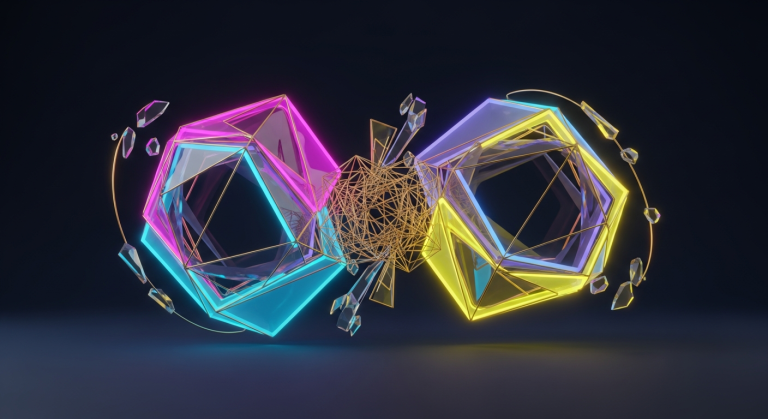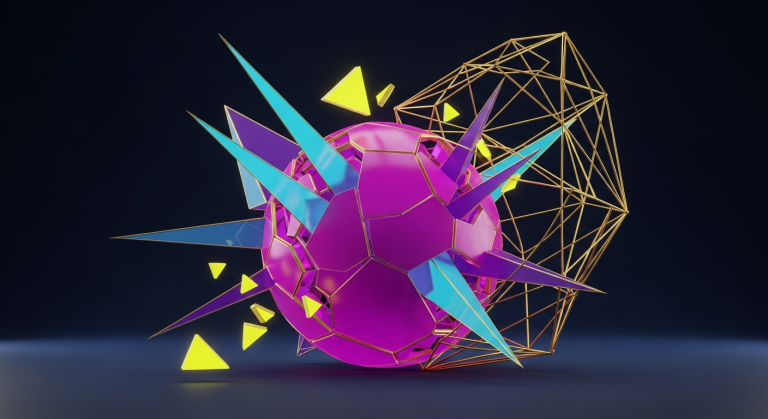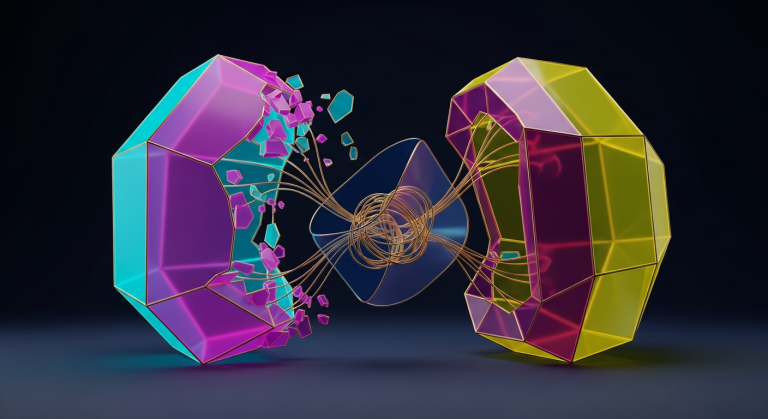La crescita del fatturato, trainata da domanda estera e investimenti in digitalizzazione e IA, disegna un settore a due velocità.
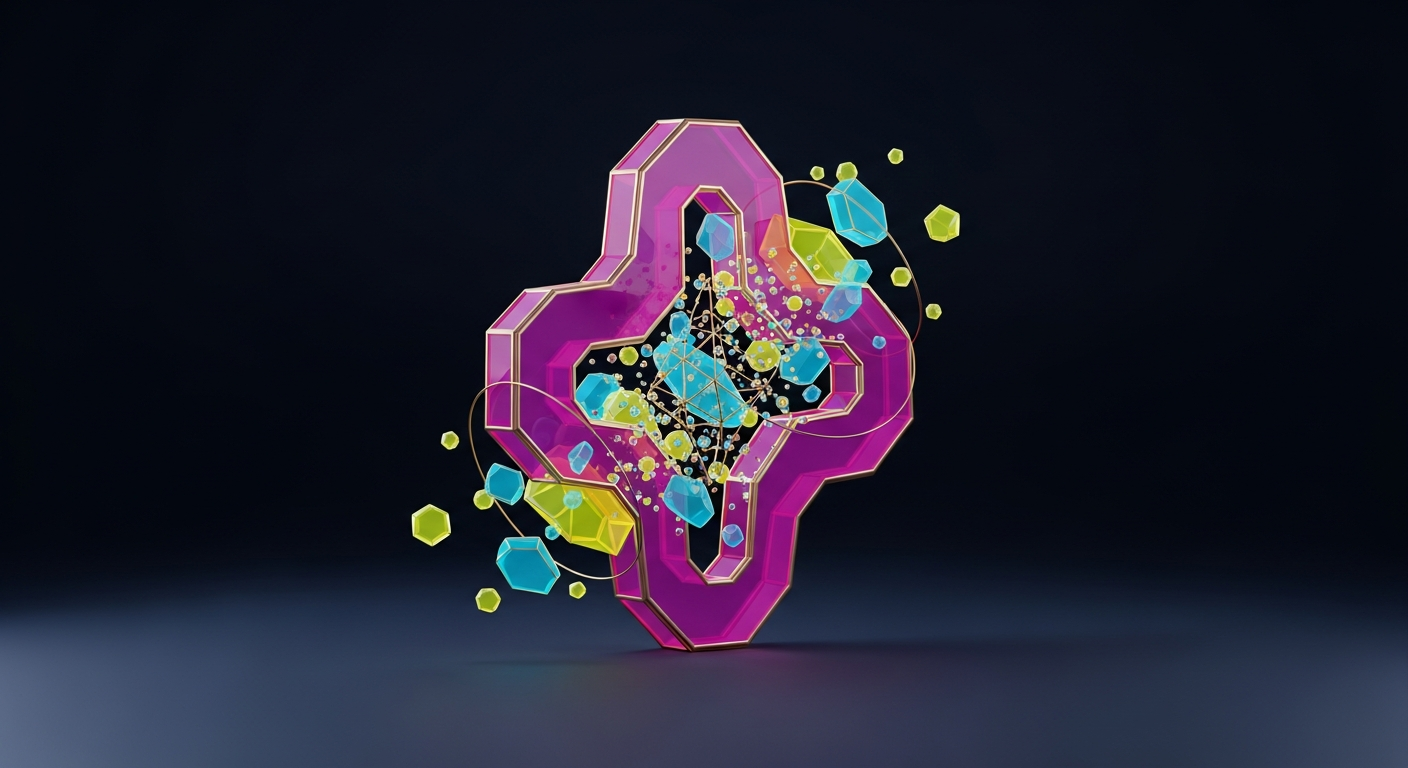
[In pillole] La sintesi per chi va di fretta:
Il manifatturiero italiano affronta un 2025 di moderata ripresa (+1,8% fatturato), spinto da export e investimenti in digitalizzazione e AI. La crescita è però disomogenea, delineando un'industria a due velocità. L'adozione di tecnologie avanzate per efficienza e gestione del rischio è cruciale, ma pone nuove sfide, in particolare per le PMI, richiedendo un approccio strategico.
Il doppio binario della produzione italiana
Ad alimentare la crescita, per quanto contenuta, sono soprattutto due elementi: le esportazioni e gli investimenti. Da un lato, la capacità delle imprese italiane di competere sui mercati internazionali continua a essere un pilastro fondamentale, specialmente in settori di eccellenza come la meccanica, la farmaceutica e l’alimentare. Dall’altro, si assiste a una ripresa degli investimenti, che rappresentano il vero motore del cambiamento.
Non si tratta, però, di investimenti generici, ma di spese mirate all’ammodernamento tecnologico, alla sostenibilità e, soprattutto, alla digitalizzazione dei processi produttivi, un percorso spesso identificato con il termine “Industria 4.0”.
Questo orientamento è confermato anche da uno studio di Prometeia, che descrive una crescita “moderata ma solida” per i settori industriali italiani, sottolineando come la capacità di innovare sia diventata il principale fattore di differenziazione competitiva. Le aziende che investono in automazione, sviluppo dell’intelligenza artificiale e analisi dei dati non solo ottimizzano la produzione e riducono i costi, ma acquisiscono anche una maggiore flessibilità, diventando capaci di adattarsi più rapidamente ai cambiamenti della domanda globale.
L’adozione di sistemi intelligenti permette di passare da un modello produttivo rigido a uno più dinamico, in cui le macchine possono dialogare tra loro e con i sistemi gestionali, anticipare guasti e ottimizzare l’uso delle risorse.
Tuttavia, questo percorso di trasformazione non è alla portata di tutti e rischia di creare un’industria a due velocità. Da una parte ci sono le grandi aziende, con le risorse finanziarie e le competenze per implementare soluzioni tecnologiche complesse. Dall’altra, il vasto tessuto delle piccole e medie imprese (PMI), che costituisce la spina dorsale del manifatturiero italiano.
Per queste realtà, l’adozione di tecnologie avanzate può rappresentare una sfida considerevole, non solo in termini di costi, ma anche di cultura aziendale e di disponibilità di personale qualificato.
La questione, quindi, non è più se digitalizzare, ma come farlo in modo sostenibile e inclusivo, per evitare che l’innovazione diventi un fattore di ulteriore polarizzazione anziché un’opportunità per l’intero sistema.
Di fronte a questa polarizzazione, viene da chiedersi quale sia il vero fattore abilitante che permette ad alcune aziende di accelerare. Forse, la differenza non sta tanto nella strategia in sé, quanto nella sua esecuzione a terra. Potrebbe essere proprio la presenza di un sistema MES il vero catalizzatore: quello strato digitale che salda la pianificazione alla realtà produttiva, orchestrando il flusso di lavoro in tempo reale e trasformando l’efficienza da ambizione a risultato concreto.
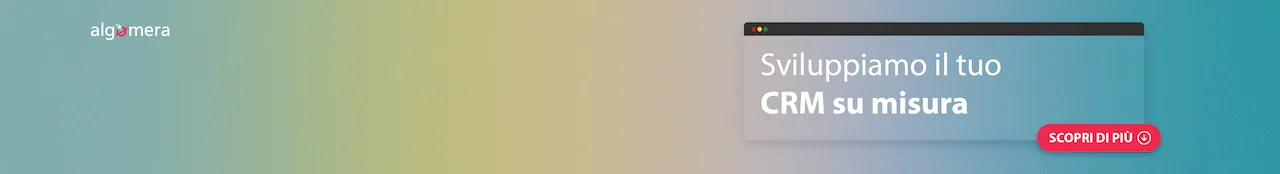
La gestione del rischio come nuovo paradigma
In questo contesto di profonda trasformazione, l’intelligenza artificiale sta emergendo non solo come uno strumento per aumentare l’efficienza, ma anche come un sistema per gestire e mitigare i rischi operativi. Le aziende manifatturiere si trovano ad affrontare una serie di minacce sempre più complesse: dalle interruzioni delle catene di approvvigionamento globali alla volatilità dei prezzi delle materie prime, passando per i rischi legati alla sicurezza informatica e alla conformità normativa.
L’uso di algoritmi predittivi e sistemi di monitoraggio intelligenti sta diventando una pratica sempre più diffusa per anticipare i problemi prima che si manifestino, trasformando la gestione del rischio da un’attività reattiva a un processo proattivo e strategico.
L’applicazione dell’AI in questo ambito è molto concreta. Ad esempio, attraverso l’analisi di enormi quantità di dati provenienti da sensori installati sui macchinari, gli algoritmi di manutenzione predittiva possono prevedere con grande accuratezza quando un componente è a rischio di guasto. Questo consente di pianificare gli interventi di manutenzione in modo mirato, evitando fermi macchina improvvisi che possono costare milioni di euro in perdita di produzione.
Allo stesso modo, sistemi di AI possono monitorare in tempo reale le catene di fornitura, analizzando dati su traffico, condizioni meteorologiche, stabilità geopolitica e performance dei fornitori per identificare potenziali colli di bottiglia e suggerire percorsi alternativi.
– Leggi anche: Amazon e Perplexity AI: lo scontro legale che modella il commercio agentivo
Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie solleva anche interrogativi importanti. L’affidamento a sistemi decisionali automatizzati, per quanto sofisticati, introduce nuove forme di vulnerabilità.
Cosa succede se l’algoritmo commette un errore di valutazione?
Chi è responsabile se una previsione sbagliata causa un danno economico?
Inoltre, la raccolta e l’analisi di dati così dettagliati sulla produzione e sulla logistica pongono questioni rilevanti in termini di sicurezza e proprietà intellettuale. La vera sfida per le aziende non è quindi solo quella di implementare la tecnologia, ma di creare un quadro di governance solido che ne regoli l’uso, definisca le responsabilità e garantisca che l’intelligenza artificiale rimanga uno strumento al servizio delle persone e della strategia aziendale, e non il contrario.
L’intelligenza artificiale autorizzata e il fattore umano
La crescente consapevolezza di questi rischi sta spingendo verso un nuovo approccio: l’uso “autorizzato” dell’intelligenza artificiale. Non si tratta più di implementare soluzioni tecnologiche in modo indiscriminato, ma di integrarle all’interno di processi ben definiti, in cui il ruolo dell’algoritmo è quello di supportare le decisioni umane, non di sostituirle completamente.
Questo significa creare sistemi in cui gli output dell’AI sono trasparenti, interpretabili e soggetti a verifica da parte di personale qualificato. L’idea è quella di un’intelligenza artificiale che agisce come un “copilota” per manager e operatori, fornendo analisi e suggerimenti basati sui dati, ma lasciando la decisione finale all’essere umano.
Questo modello, che combina la potenza di calcolo delle macchine con l’esperienza e l’intuito delle persone, sembra essere la strada più promettente per il futuro del manifatturiero. Richiede, però, un cambiamento culturale profondo e un forte investimento nella formazione.
Non servono solo data scientist e ingegneri informatici, ma anche operai, tecnici e manager in grado di comprendere il funzionamento di questi sistemi, di dialogarne e di metterne in discussione i risultati. La vera trasformazione digitale, come evidenziato da diverse analisi sul settore, non riguarda tanto l’acquisto di nuovo software, quanto la capacità di ripensare i processi e valorizzare le competenze delle persone in un contesto tecnologicamente avanzato.
Il 2025 si profila quindi come un anno di transizione non solo economica, ma anche strategica e culturale. La capacità del sistema manifatturiero italiano di cogliere appieno le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale dipenderà non tanto dalla velocità di adozione della tecnologia, quanto dalla saggezza con cui verrà integrata nei processi aziendali.
La sfida sarà quella di trovare un equilibrio tra automazione e controllo umano, tra efficienza e resilienza, tra la promessa di un futuro iper-tecnologico e la necessità di mantenere al centro il valore insostituibile del lavoro e dell’intelligenza delle persone.