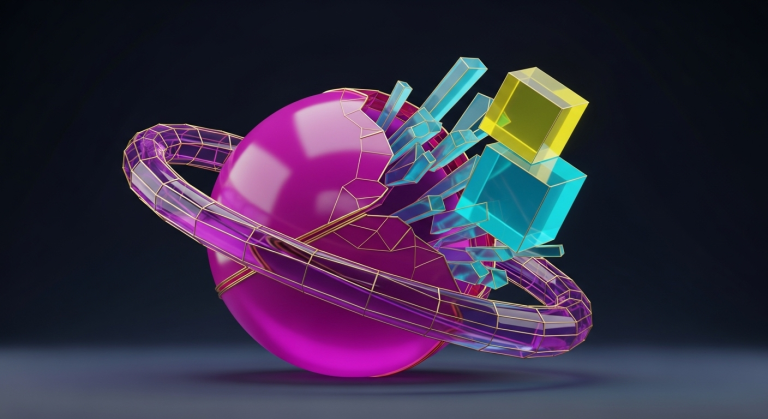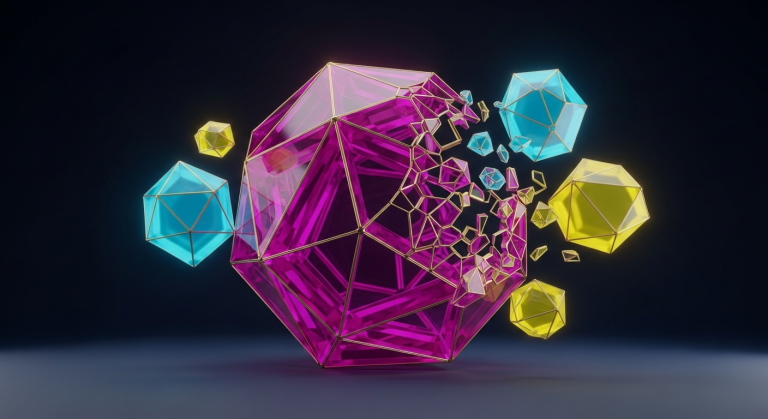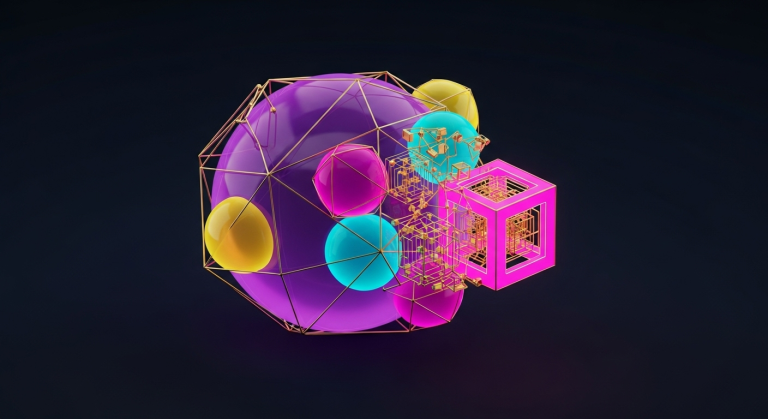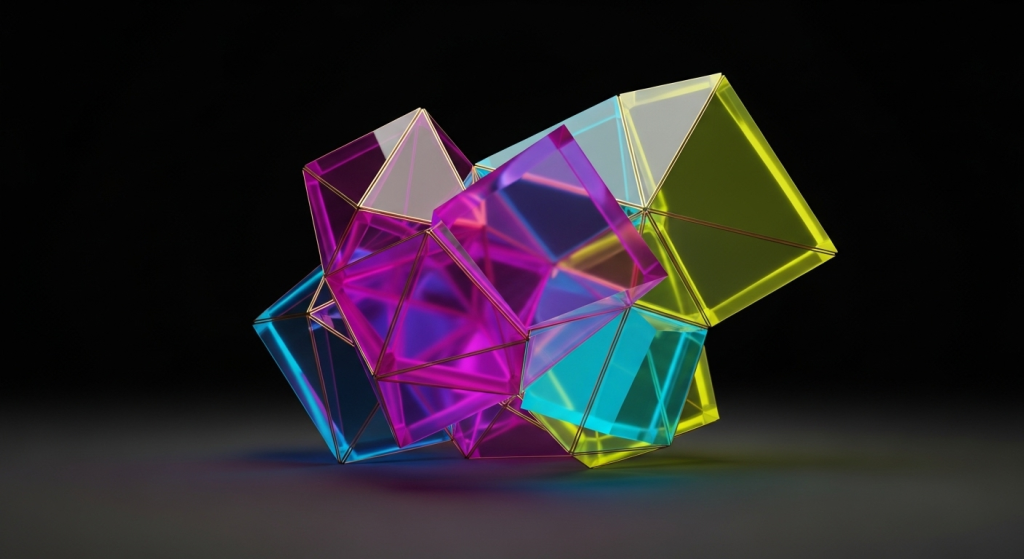Il manager di Meta descrive una realtà operativa consolidata in cui l’AI è il motore invisibile che plasma l’esperienza degli utenti e il modello di business delle piattaforme social.
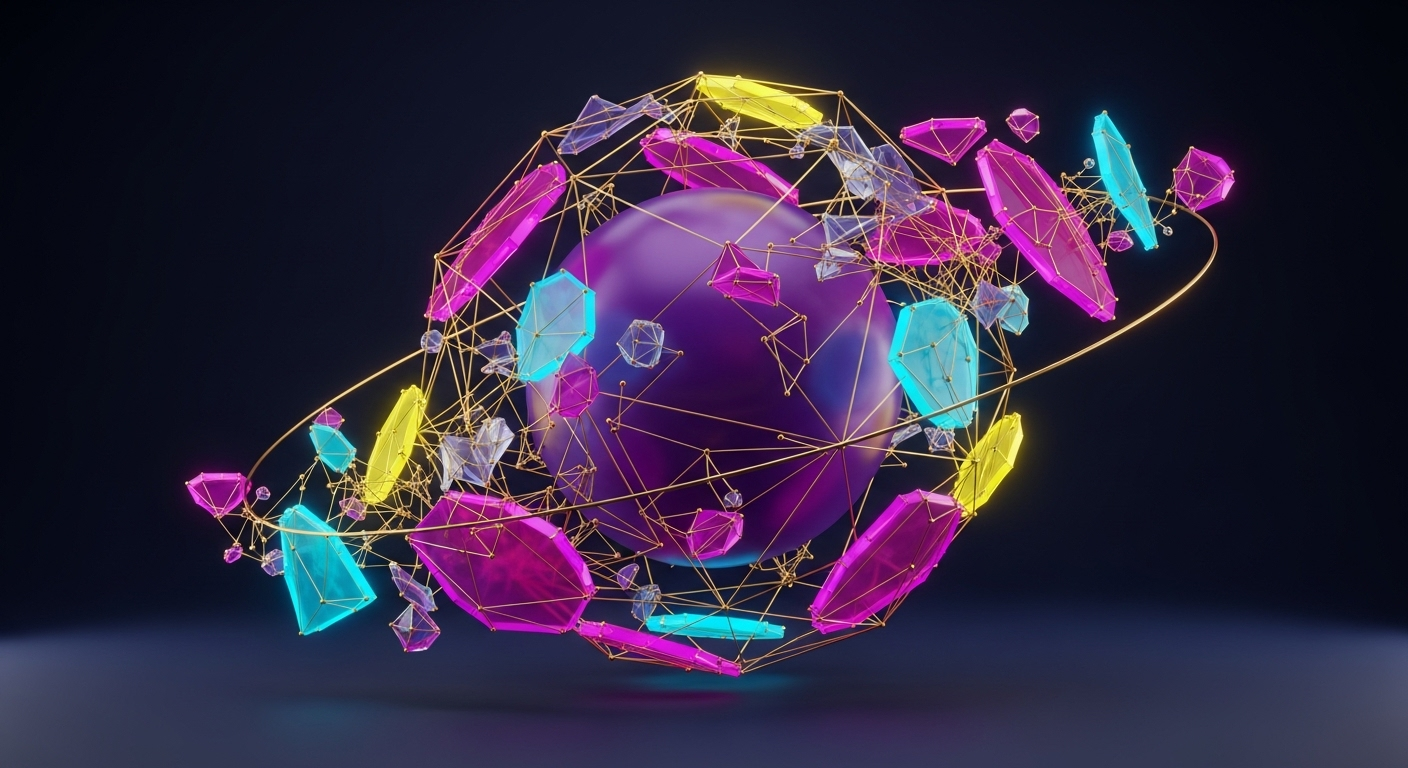
[In pillole] La sintesi per chi va di fretta:
Meta considera l'intelligenza artificiale una componente ineludibile, come affermato dal Product Manager Nisarg Shah. Non una previsione, ma una realtà operativa che modella quotidianamente le piattaforme social. L'AI è il motore di personalizzazione ed engagement, definendo il futuro dell'interazione digitale di miliardi. Emergono questioni di trasparenza e controllo per gli utenti.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale secondo chi la progetta
Per capire il peso delle dichiarazioni di Shah, è utile soffermarsi sul suo ruolo. Un Product Manager in una grande azienda tecnologica non è un semplice programmatore né un puro stratega di marketing; è una figura che si colloca all’intersezione tra le esigenze del business, le possibilità offerte dalla tecnologia e l’esperienza dell’utente. Il suo compito è tradurre gli obiettivi commerciali in funzionalità concrete.
Shah, con un’esperienza di oltre quindici anni in aziende come Amazon e Meta, ha contribuito a lanciare prodotti che utilizzano l’intelligenza artificiale per modellare le nostre abitudini, come Amazon Prime Video Watch Party o Instagram Trends. Si tratta di strumenti che, pur apparendo come semplici comodità, sono in realtà il frutto di complessi sistemi di analisi e previsione del comportamento umano.
Come riportato in un’intervista su AI Time Journal, la visione di Shah riflette una filosofia aziendale precisa: il potenziale dell’intelligenza artificiale è “troppo significativo” per essere ignorato. Questa affermazione, apparentemente neutra, nasconde una necessità competitiva.
In un mercato digitale saturo, dove la vera merce di scambio è il tempo degli utenti, la capacità di offrire un’esperienza altamente personalizzata è ciò che distingue una piattaforma di successo da una destinata all’irrilevanza. L’intelligenza artificiale è lo strumento principale per raggiungere questo obiettivo, analizzando enormi quantità di dati per prevedere cosa potrebbe piacerci, cosa potrebbe farci arrabbiare, cosa potrebbe spingerci a commentare o a condividere.
Questa logica, tuttavia, solleva una domanda fondamentale: se per le aziende l’adozione dell’intelligenza artificiale è una questione di sopravvivenza commerciale, quali sono le conseguenze per chi, ogni giorno, si trova dall’altra parte dello schermo?
La personalizzazione spinta all’estremo rischia di trasformarsi in un meccanismo che non si limita a rispondere ai nostri gusti, ma contribuisce attivamente a formarli, rafforzando convinzioni esistenti e limitando l’esposizione a punti di vista differenti. È un processo sottile, che avviene senza che l’utente ne abbia piena consapevolezza, ma che ha un impatto profondo sulla sua percezione del mondo.
Questo processo non è casuale, ma il risultato di decisioni precise. È nel campo della progettazione di interfacce e user experience (UI/UX) che si definisce l’equilibrio tra un’esperienza coinvolgente e il rispetto della consapevolezza dell’utente, un confine etico sempre più cruciale.
Una trasformazione non più opzionale
L’idea che l’intelligenza artificiale non sia più “opzionale” può essere interpretata in due modi.
Da un lato, c’è la prospettiva aziendale: per una società come Meta, rinunciare agli algoritmi di raccomandazione significherebbe perdere il proprio vantaggio competitivo e, di conseguenza, la propria base di utenti e i propri ricavi pubblicitari. Gli algoritmi sono il cuore pulsante del modello di business, il meccanismo che trasforma i dati degli utenti in profitti. In questo senso, la dichiarazione di Shah è una semplice ammissione di dipendenza tecnologica ed economica.
L’azienda non può farne a meno, perché l’intera struttura si fonda su di essa.
Dall’altro lato, però, c’è la prospettiva dell’utente.
Anche per chi usa le piattaforme, l’intelligenza artificiale è sempre meno opzionale. Non esiste un interruttore per “disattivare l’algoritmo” e tornare a un feed puramente cronologico e non filtrato, se non in forme limitate e spesso poco accessibili. L’utente è immerso in un ambiente progettato da questi sistemi, che mediano la sua relazione con le informazioni e con le altre persone.
– Leggi anche: OpenAI e Oracle firmano un accordo storico da 300 miliardi di dollari per l’infrastruttura AI
La “trasformazione” di cui parla Shah non è quindi solo tecnologica, ma anche sociale e culturale. Ha cambiato il modo in cui ci informiamo, come formiamo le nostre opinioni e persino come percepiamo il consenso sociale su determinati argomenti.
Questa inevitabilità pone un problema di trasparenza e controllo.
Se non possiamo scegliere di sottrarci a questi sistemi, dovremmo almeno poter capire come funzionano e avere un maggiore controllo su di essi. Iniziative come la funzione “Interested/Not Interested” di Instagram, a cui Shah ha lavorato, vengono presentate come un passo in questa direzione. Permettono all’utente di fornire un feedback esplicito all’algoritmo, contribuendo a personalizzare ulteriormente l’esperienza.
Tuttavia, è lecito chiedersi se questi strumenti rappresentino una vera cessione di potere all’utente o, piuttosto, un modo più sofisticato per raccogliere dati ancora più precisi sulle sue preferenze, rendendo l’algoritmo ancora più efficace nel suo compito originario: mantenere l’utente sulla piattaforma il più a lungo possibile.
La personalizzazione come motore del modello di business
Il fulcro del discorso di Shah, e della strategia di Meta, risiede nel concetto di “potenziale trasformativo”. Per l’azienda, questo potenziale si traduce in una capacità senza precedenti di personalizzare i contenuti su scala globale.
Ogni “mi piace”, ogni secondo passato a guardare un video, ogni commento e ogni condivisione viene registrato e analizzato per costruire un profilo dinamico di ciascun utente. Questo profilo non serve solo a mostrare pubblicità pertinenti, ma a orchestrare l’intera esperienza sulla piattaforma, con l’obiettivo di massimizzare il tempo di permanenza. Una permanenza che non è fine a sé stessa, ma serve ad alimentare il motore commerciale della piattaforma. Un utente più coinvolto è un utente più esposto a messaggi pubblicitari mirati, che sono il ponte diretto tra l’engagement sui social e il mondo dello sviluppo di eCommerce, dove quell’attenzione viene infine monetizzata.
Il sistema di raccomandazione di Instagram o Facebook, ad esempio, non si limita a suggerire contenuti simili a quelli con cui abbiamo interagito in passato. Cerca di anticipare i nostri interessi emergenti, di capire il nostro stato d’animo e di proporci contenuti che possano suscitare una reazione emotiva, che sia positiva o negativa.
Questo perché l’interazione, di qualsiasi tipo, è un segnale forte per l’algoritmo e un indicatore del fatto che l’utente è coinvolto. La conseguenza è che i contenuti più polarizzanti, controversi o emotivamente carichi hanno spesso una maggiore probabilità di essere amplificati, perché generano più reazioni.
Questa dinamica solleva questioni etiche significative, che vanno oltre la semplice efficienza commerciale.
Un sistema ottimizzato per massimizzare l’interazione potrebbe, involontariamente, favorire la diffusione di disinformazione, estremizzare il dibattito pubblico e creare bolle informative in cui gli utenti sono esposti solo a contenuti che confermano le loro idee.
Sebbene le aziende tecnologiche affermino di lavorare costantemente per mitigare questi rischi, il conflitto di interessi è evidente: l’obiettivo primario del sistema rimane quello di massimizzare l’engagement, e qualsiasi modifica che riduca questo parametro, anche se a beneficio della qualità dell’informazione, rischia di essere vista come un danno per il business.
Le parole di Nisarg Shah, quindi, pur essendo quelle di un tecnico, descrivono un dilemma profondamente politico e sociale. La questione non è più se l’intelligenza artificiale modellerà il nostro accesso all’informazione e le nostre interazioni sociali, perché lo sta già facendo in modo pervasivo.
La vera domanda è con quali regole, con quale grado di supervisione e, soprattutto, con quale consapevolezza da parte degli utenti debba operare questa tecnologia che, come ammesso dai suoi stessi creatori, non è più una semplice opzione.