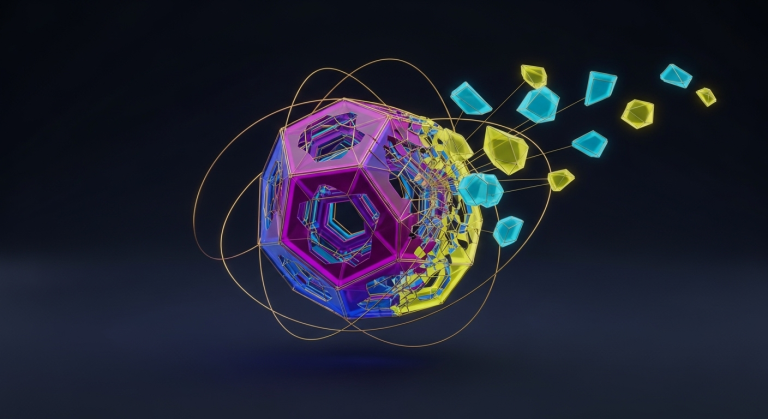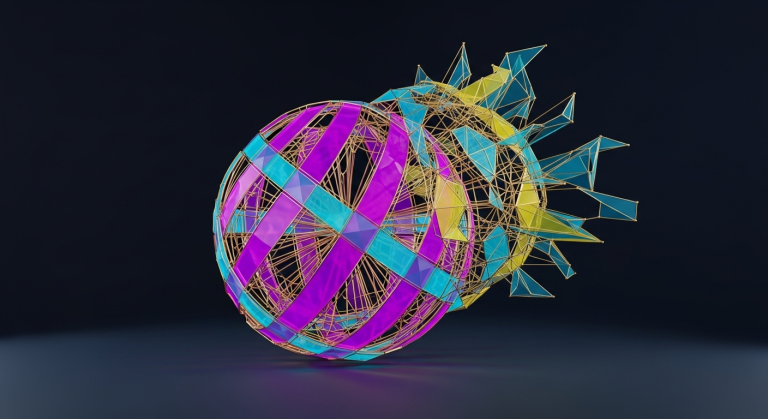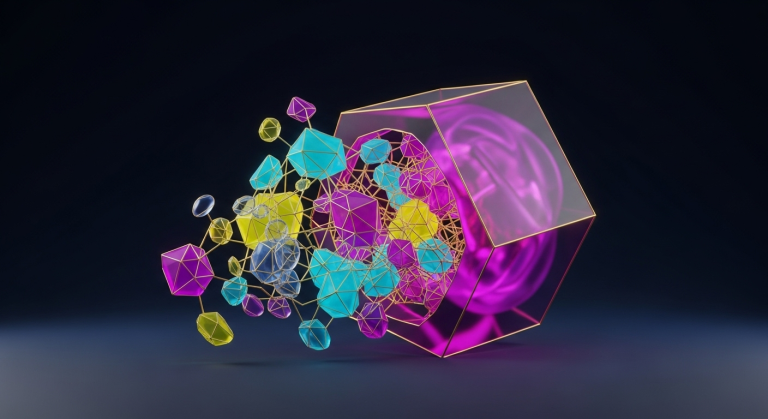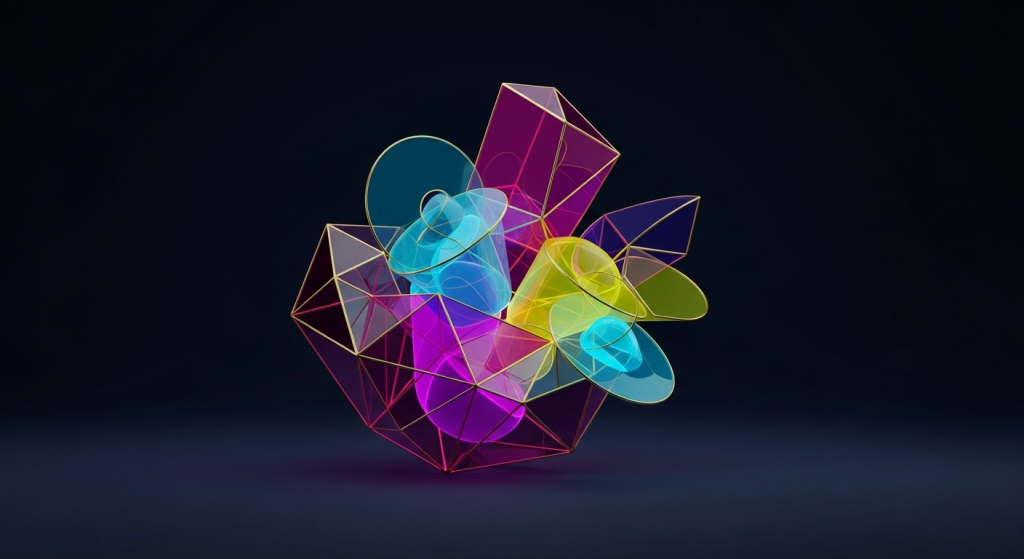Questa ondata di automazione sta ridefinendo i poteri industriali mondiali e sollevando domande profonde sul futuro del lavoro e sulle dipendenze tecnologiche.
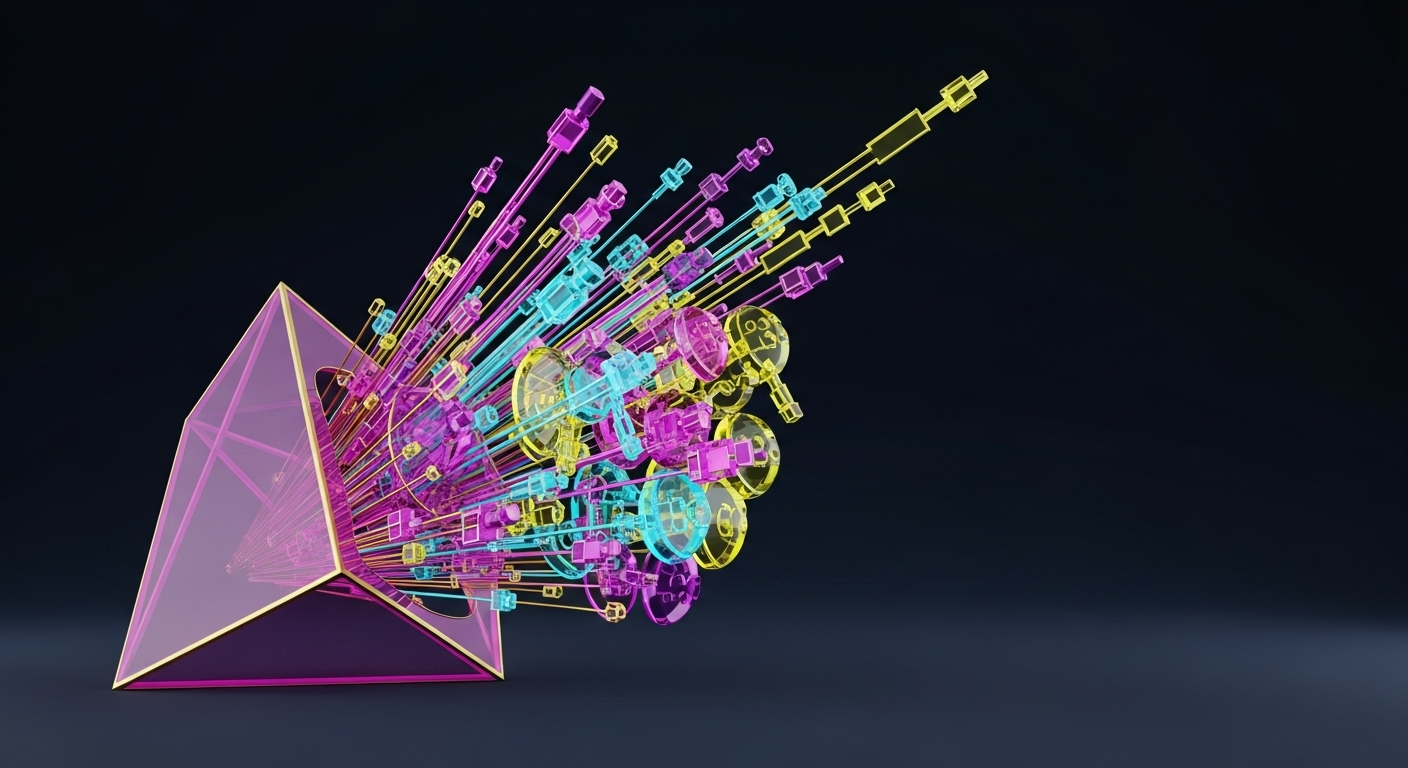
[In pillole] La sintesi per chi va di fretta:
Nel 2024, 542.000 nuovi robot industriali sono stati installati, portando il totale globale a quasi 4,7 milioni. La Cina è il motore principale, assorbendo il 54% delle nuove unità e con i suoi produttori che per la prima volta superano i concorrenti stranieri. Questa accelerazione, guidata da elettronica e automotive, ridefinisce gli equilibri industriali mondiali, ponendo sfide significative sull'impatto sociale del lavoro.
La grande accelerazione dei robot nelle fabbriche, guidata dalla Cina
Negli ultimi dieci anni, il numero di robot industriali installati nelle fabbriche di tutto il mondo è più che raddoppiato. È un dato che, da solo, racconta una trasformazione profonda e silenziosa del modo in cui produciamo quasi ogni cosa. Nel 2024 sono stati installati 542.000 nuovi robot, un numero che si avvicina al record storico di due anni fa e che porta il totale dei robot operativi a livello globale a quasi 4,7 milioni.
Questi dati, come descritto dalla International Federation of Robotics (IFR) nel suo ultimo rapporto World Robotics 2025, non indicano semplicemente una tendenza alla crescita, ma delineano una nuova geografia del potere industriale e tecnologico. L’automazione non è più un’opzione per pochi settori all’avanguardia, ma una componente strutturale della produzione manifatturiera globale, con un ritmo di adozione che continua a sorprendere.
Questa accelerazione, tuttavia, non è distribuita in modo uniforme sul pianeta. Anzi, è trainata in maniera preponderante da un singolo attore che, da solo, rappresenta più della metà dell’intera domanda mondiale.
La storia di questa crescita è, in gran parte, la storia di come la Cina abbia deciso di ripensare radicalmente le proprie fabbriche, con implicazioni che vanno ben oltre i suoi confini e che stanno ridisegnando gli equilibri competitivi su scala globale.
L’inarrestabile ascesa della Cina
Il ruolo della Cina in questa trasformazione è difficile da sopravvalutare. Con 295.000 nuovi robot installati solo nel 2024, il paese ha assorbito il 54% di tutte le nuove unità a livello mondiale, portando il suo parco macchine operativo a superare i due milioni. Per dare un’idea della velocità di questa evoluzione, basti pensare che lo stock di robot in Cina è raddoppiato in appena tre anni.
Ma il dato forse più significativo è un altro: per la prima volta, i produttori cinesi di robot hanno venduto sul loro mercato interno più unità dei concorrenti stranieri, raggiungendo una quota del 57%. Fino a un decennio fa, questa quota era inferiore al 30%, a dimostrazione di una dipendenza quasi totale dalla tecnologia giapponese, tedesca e statunitense.
Questo sorpasso non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori, ma un segnale strategico di enorme portata. Indica che la Cina non è più soltanto il più grande mercato per l’automazione, ma sta diventando anche un produttore autonomo e competitivo, capace di soddisfare la propria immensa domanda interna.
L’obiettivo, chiaramente, è ridurre la dipendenza tecnologica dall’estero e consolidare una filiera nazionale completa, un pilastro della sua strategia di modernizzazione industriale. Takayuki Ito, presidente della IFR, ha sottolineato come questo traguardo rappresenti una “nuova pietra miliare” nella spinta del paese verso l’automazione.
– Leggi anche: Intelligenza artificiale crea i primi virus sintetici: un punto di svolta per la biologia, ma con rischi
Dietro la narrazione ufficiale di efficienza e modernizzazione, però, si cela una manovra geopolitica precisa. Per le grandi multinazionali della robotica, la perdita di quote in un mercato così vasto non è una buona notizia e solleva interrogativi sulla loro capacità di competere nel lungo periodo con aziende che possono contare su un forte sostegno statale.
Questo cambiamento non avviene in modo casuale, ma segue una logica industriale precisa. La domanda cinese è trainata principalmente dal settore dell’elettronica e dell’automotive, due industrie ad alta intensità di capitale e precisione. Tuttavia, i produttori locali stanno guadagnando terreno anche in settori più tradizionali, come quello alimentare, tessile e della lavorazione del legno.
Si tratta di una penetrazione capillare che mostra come l’automazione non sia più relegata alle produzioni di alta gamma, ma stia diventando uno standard diffuso.
Questo spostamento degli equilibri, concentrato in Asia, lascia però il resto del mondo in una posizione molto diversa.
Chi compra davvero i robot?
Se l’Asia rappresenta il 74% di tutte le nuove installazioni di robot, l’Europa si ferma al 16% e le Americhe appena al 9%. Questi numeri mostrano un divario evidente nelle strategie di investimento e nelle priorità industriali.
Dopo la Cina, il secondo mercato più grande rimane il Giappone, con circa 44.500 installazioni, seguito dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. Sebbene gli Stati Uniti rappresentino quasi il 70% delle installazioni nel continente americano, i loro numeri appaiono modesti se confrontati con la scala dell’espansione asiatica.
Questa disparità geografica suggerisce che mentre in Asia l’automazione è vista come una leva strategica per la competitività futura, in altre parti del mondo la sua adozione procede con un ritmo più cauto, forse anche a causa di strutture industriali diverse, normative sul lavoro più rigide o una diversa percezione dei costi e dei benefici.
L’analisi dei settori che guidano la domanda offre un ulteriore livello di comprensione. L’industria elettronica, con la sua necessità di assemblare componenti sempre più piccoli e complessi con margini di errore minimi, è il primo motore a livello globale.
Segue a ruota l’industria automobilistica, che è stata pioniera nell’uso dei robot fin dagli anni ’70 e che oggi continua ad automatizzare nuove fasi del processo produttivo, specialmente con la transizione verso i veicoli elettrici.
La crescente sofisticazione dei robot, dotati di sensori avanzati e intelligenza artificiale, sta inoltre aprendo le porte a settori un tempo considerati difficili da automatizzare.
La questione che rimane aperta, e che spesso viene lasciata in secondo piano nei rapporti entusiastici di settore, riguarda l’impatto sociale di una transizione così rapida.
L’automazione promette di liberare gli esseri umani da compiti ripetitivi e pericolosi, ma il ritmo con cui sta avvenendo rischia di creare uno squilibrio significativo nel mercato del lavoro, specialmente per i lavoratori con qualifiche medio-basse.
La narrazione prevalente, promossa dalle aziende produttrici e dalle grandi corporazioni che adottano queste tecnologie, è quella di un progresso inevitabile e universalmente benefico.
Eppure, la velocità con cui milioni di postazioni di lavoro vengono trasformate o eliminate pone una sfida enorme ai sistemi di formazione e di welfare.
Ci si chiede se la creazione di nuovi ruoli professionali, la cui gestione e pianificazione richiede sempre di più una moderna piattaforma di gestione delle risorse umane, possa davvero compensare, in termini numerici e di tempistiche, la sostituzione di quelli vecchi.
L’automazione non è un processo neutrale; è una scelta che ridistribuisce valore e che, se non governata, rischia di accentuare le disuguaglianze.
Un futuro già scritto o una scommessa complessa?
Le proiezioni della IFR indicano che la crescita non si fermerà. Si prevede che le installazioni globali supereranno le 575.000 unità nel 2025 e potrebbero raggiungere le 700.000 entro il 2028.
Questa traiettoria sembra indicare che l’automazione spinta sia diventata la norma, una sorta di strada obbligata per qualsiasi paese o azienda che voglia rimanere competitiva sulla scena globale.
Il modello è quello di una fabbrica sempre più interconnessa, flessibile e autonoma, dove il lavoro umano si concentra sulla supervisione, la manutenzione e la programmazione, piuttosto che sull’esecuzione materiale. Un modello che, sulla carta, promette efficienza e produttività senza precedenti.
Questo modello di fabbrica interconnessa, tuttavia, non si regge solo sui robot. La vera intelligenza risiede nel software che li orchestra. Nel mondo dell’industria 4.0, questo “cervello” digitale ha un nome preciso: è il Sistema di Esecuzione della Produzione (MES), la piattaforma che sincronizza i dati dalla produzione alla logistica, trasformando un insieme di macchine in un organismo produttivo coerente.
Tuttavia, questa visione nasconde delle complessità e dei rischi non trascurabili.
Una dipendenza così massiccia dall’automazione crea nuove vulnerabilità. Le fabbriche intelligenti sono esposte a rischi di sicurezza informatica; le catene di approvvigionamento dei robot e dei loro componenti sono concentrate in poche aree geografiche; e i costi iniziali di investimento rimangono una barriera per le piccole e medie imprese, che rischiano di essere schiacciate dalla maggiore efficienza dei grandi gruppi industriali.
Questo potrebbe portare a una ulteriore concentrazione del potere economico nelle mani di poche, gigantesche corporazioni multinazionali, capaci di sostenere investimenti di questa portata.
La domanda fondamentale, quindi, non è se l’automazione continuerà a diffondersi, ma come governeremo questa transizione.
La spinta verso la fabbrica del futuro, presentata come un’inevitabile evoluzione tecnologica, è in realtà il risultato di precise scelte politiche ed economiche. Scelte che privilegiano la produttività del capitale rispetto al costo del lavoro e che, nel farlo, stanno riscrivendo le regole del gioco.
Resta da vedere se i benefici di questa enorme ondata di automazione saranno distribuiti in modo equo o se, al contrario, contribuiranno ad approfondire le fratture economiche e sociali già esistenti, lasciando indietro chi non riesce a tenere il passo di questa incessante accelerazione.