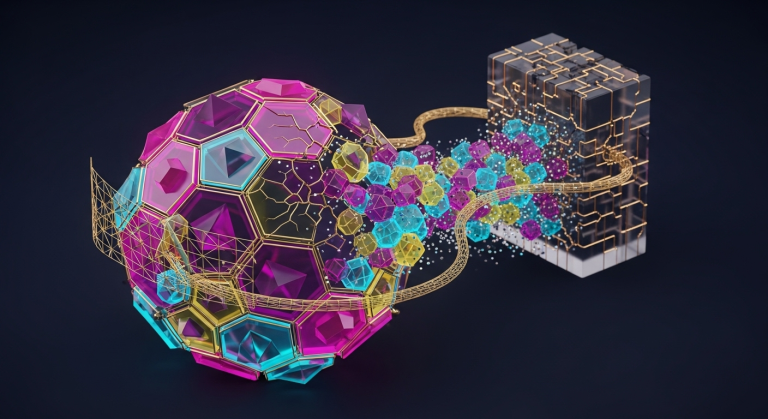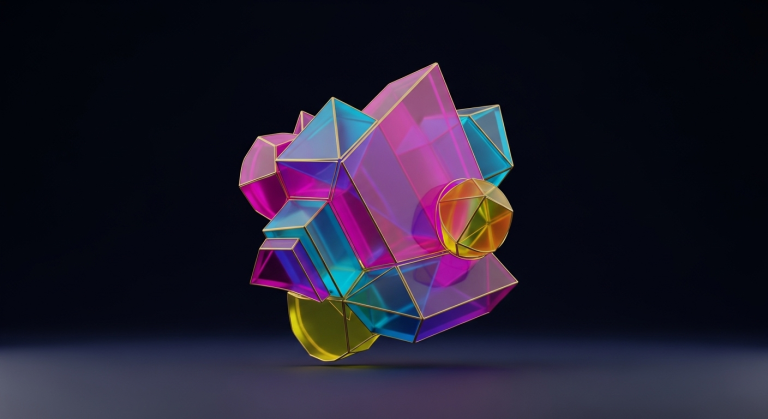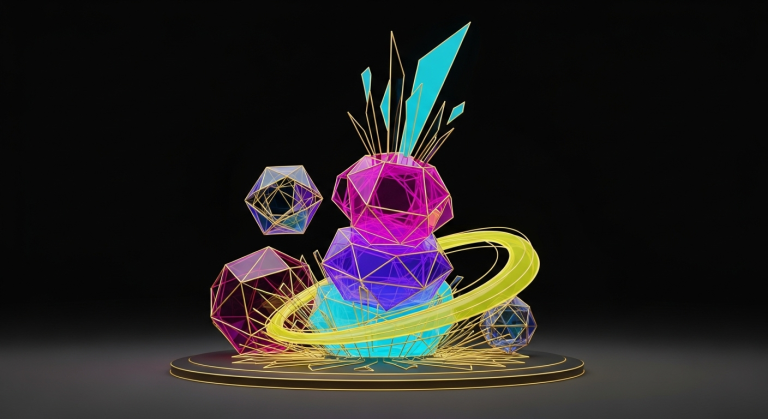Questa trasformazione silenziosa e pervasiva sta ridefinendo i confini del ruolo accademico, richiedendo un delicato equilibrio tra la missione pubblica e le logiche di mercato, con impatti sulla gestione interna e sulla formazione delle future classi dirigenti.
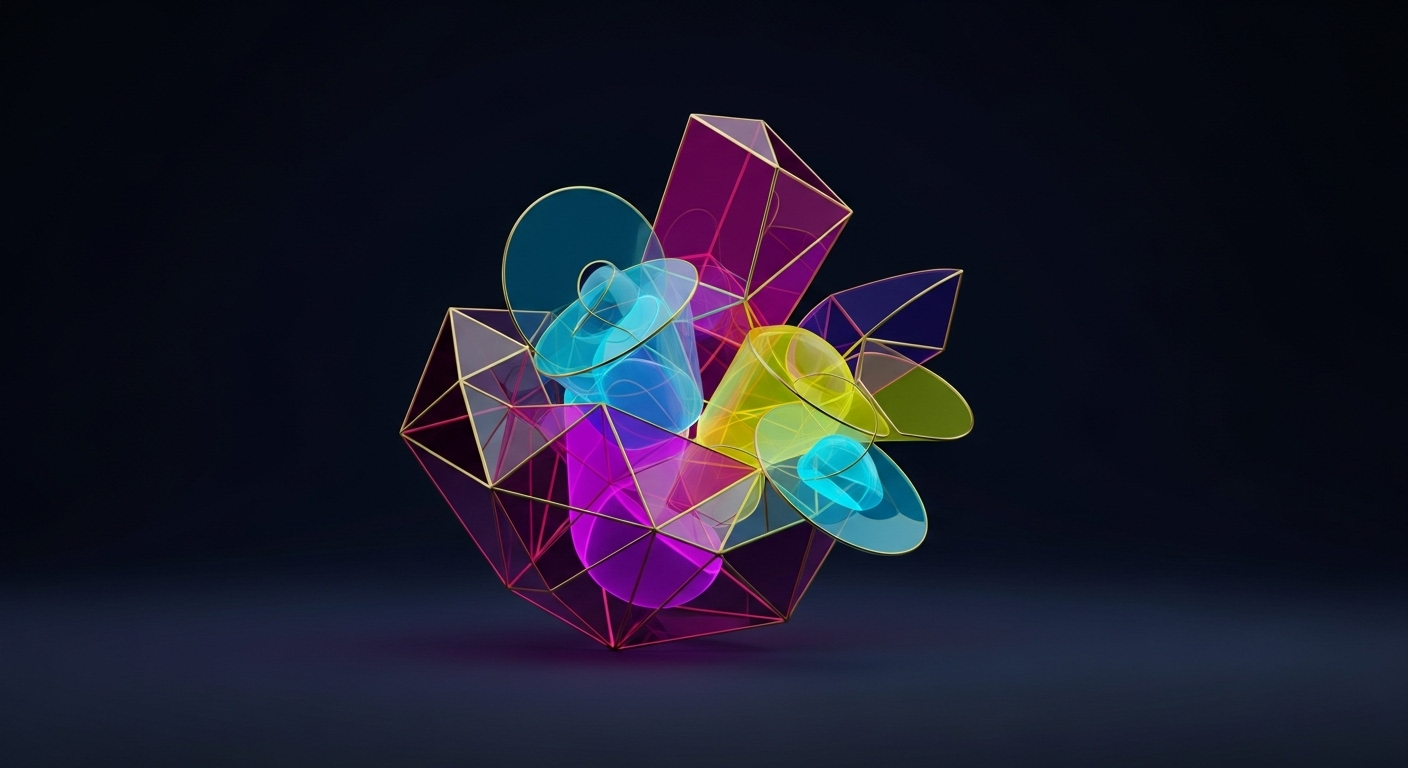
[In pillole] La sintesi per chi va di fretta:
Le università italiane si evolvono, diventando complesse organizzazioni managerializzate. Sfide come sostenibilità, competizione e digitalizzazione ridefiniscono il ruolo di atenei e manager. La trasformazione investe la gestione interna, la formazione per il mondo del lavoro e persino la figura del docente, ora sempre più "imprenditore". È cruciale trovare un nuovo equilibrio tra missione pubblica e logiche di mercato.
Un nuovo tipo di manager per l’università stessa
Per molto tempo, la gestione di un ateneo è stata considerata un’attività prevalentemente amministrativa, quasi burocratica. Oggi, questa visione è del tutto superata.
Le università sono diventate imprese della conoscenza, con bilanci complessi, centinaia di dipendenti e migliaia di “clienti”, gli studenti. La necessità di attrarre fondi, partecipare a bandi europei, gestire patrimoni immobiliari e ottimizzare i servizi richiede competenze che vanno ben oltre la semplice applicazione di norme.
Un quadro emerso con chiarezza durante l’ultimo convegno nazionale dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CODAU), come descritto da Edunews24, dove si è discusso di una managerialità universitaria che non scimmiotta semplicemente il settore privato, ma che si adatta alle specificità del mondo accademico.
Uno dei concetti più interessanti emersi è quello di “coopetizione”: un misto di cooperazione e competizione. Gli atenei italiani, pur competendo per attrarre i migliori studenti e ricercatori, stanno capendo che collaborare su progetti comuni, condividere buone pratiche amministrative o creare reti per la ricerca può portare benefici a tutto il sistema.
È un approccio pragmatico che riconosce come, di fronte a sfide globali, l’isolamento sia una strategia perdente. Questo è particolarmente vero nella fase post-PNRR, che metterà alla prova la capacità delle università di rendere sostenibili gli investimenti e le innovazioni avviate con i fondi europei, una volta che questi si saranno esauriti.
Serviranno manager capaci di pianificare a lungo termine, di gestire progetti complessi e di dialogare con il settore pubblico e privato.
Questa nuova complessità gestionale, però, non è priva di rischi. L’enfasi sull’efficienza e sulla misurazione delle performance, se applicata in modo acritico, può portare a una deriva “aziendalista” in cui il valore della ricerca e della didattica viene giudicato solo sulla base di indicatori quantitativi, a scapito della creatività e della ricerca di base, i cui frutti non sono sempre immediatamente misurabili.
Ma per gestire questa nuova macchina, servono piloti con competenze diverse. E questo apre una seconda, e forse più complessa, questione.
Come si formano, oggi, i manager?
La formazione che cambia, tra specializzazione e competenze trasversali
Se da un lato le università hanno bisogno di manager al loro interno, dall’altro il loro compito primario resta quello di formarli per il mondo esterno. E anche qui, il modello è in piena evoluzione. Le tradizionali lauree in economia e management, pur rimanendo un pilastro, stanno integrando percorsi sempre più specializzati e contaminati da altre discipline.
Analizzando l’offerta formativa di diversi atenei, da Nord a Sud, si nota una tendenza chiara: non basta più conoscere i principi del bilancio o del marketing. Ai futuri manager si chiede di comprendere le dinamiche della transizione ecologica, di saper gestire la trasformazione digitale e di avere una spiccata sensibilità per le questioni sociali e di governance (i cosiddetti criteri ESG).
Corsi di laurea magistrale come quelli in Management proposti da atenei come la Luiss o l’Università Europea di Roma si concentrano sempre più su percorsi internazionali, sull’imprenditorialità e sull’innovazione. L’obiettivo è creare figure ibride, capaci di parlare il linguaggio dei numeri ma anche quello della tecnologia e della sostenibilità.
Si insiste molto sulle “soft skills”: la capacità di lavorare in gruppo, di comunicare efficacemente, di risolvere problemi complessi – competenze che le macchine, almeno per ora, non possono replicare.
Tuttavia, questa spinta verso la specializzazione e l’adeguamento alle richieste del mercato solleva alcuni interrogativi.
– Leggi anche: LinkedIn: dati utente usati per addestrare l’Intelligenza Artificiale di default da novembre 2025
La crescente influenza delle grandi aziende e delle società di consulenza sui percorsi formativi rischia di plasmare manager molto abili dal punto di vista tecnico, ma forse meno dotati di un pensiero critico autonomo?
L’enfasi sulla “spendibilità” immediata del titolo di studio non rischia di andare a scapito di una formazione culturale più ampia, quella che permette di interpretare i cambiamenti di lungo periodo e non solo di reagire alle contingenze del mercato?
È un dubbio legittimo, perché se l’università si limita a diventare un fornitore di “risorse umane” su misura per le imprese, tradisce in parte la sua missione di formare cittadini consapevoli, oltre che professionisti competenti.
Ma la trasformazione non riguarda solo chi entrerà nel mondo del lavoro. Un dibattito ancora più profondo e per certi versi controverso sta prendendo forma all’interno degli stessi dipartimenti.
E se il manager fosse il docente stesso?
La spinta verso una maggiore managerialità non si ferma ai vertici amministrativi, ma sta progressivamente permeando anche la figura del docente universitario. L’idea, sollevata ad esempio da Federico Menna in un contributo per Forbes Italia, è che il professore del ventunesimo secolo non possa più essere solo un erudito chiuso nella sua torre d’avorio.
Oggi, un ricercatore di successo deve saper reperire finanziamenti, coordinare team di ricerca internazionali, gestire budget, depositare brevetti e dialogare con le imprese per il trasferimento tecnologico. In pratica, deve agire come il manager di un piccolo progetto imprenditoriale.
Questo modello del “docente-imprenditore” ha indubbiamente dei vantaggi. Rende la ricerca più dinamica e connessa ai bisogni della società, incentiva l’innovazione e può portare risorse preziose agli atenei. Molti dei più grandi progressi scientifici degli ultimi anni sono nati proprio dalla capacità dei ricercatori di operare su questa frontiera tra accademia e industria.
Questa evoluzione è un segnale di un cambiamento più ampio nel mondo della governance e della leadership, un segnale che si ritrova anche in contesti contigui, come nella recente elezione di Marco Spinetto a nuovo presidente di UNI, l’ente italiano di normazione.
Allo stesso tempo, però, questa trasformazione nasconde delle insidie.
Se la carriera accademica finisce per premiare soprattutto la capacità di attrarre fondi, cosa ne è della ricerca di base, quella spinta dalla pura curiosità, che non ha un’applicazione pratica immediata ma che storicamente ha posto le fondamenta per le più grandi scoperte?
Esiste il rischio che i docenti, oberati da compiti gestionali e burocratici, che una moderna piattaforma di gestione delle risorse umane potrebbe automatizzare, abbiano meno tempo da dedicare alla didattica e al rapporto con gli studenti, che pure dovrebbe essere al centro della loro missione. La pressione a pubblicare e a ottenere risultati economicamente valutabili potrebbe scoraggiare la ricerca su temi controversi o di nicchia, uniformando il panorama scientifico.
In definitiva, la rivoluzione manageriale che sta attraversando l’università italiana è un processo complesso, fatto di luci e ombre. Da un lato, c’è la necessità ineludibile di rendere il sistema più efficiente, moderno e competitivo a livello globale.
Dall’altro, c’è il rischio di importare modelli che, se non adattati con intelligenza e senso critico, rischiano di erodere i valori fondamentali su cui l’istituzione universitaria si fonda: l’autonomia del pensiero, la libertà della ricerca e la formazione integrale della persona.
La vera sfida, per i manager di oggi e di domani, sarà trovare un nuovo, delicato equilibrio.